
Per la serie “Quando un personaggio ha la meglio sul suo autore”: dopo avere scritto di lui in Califia, con il poemetto L’innato autolesionismo del plantigrado che volendo potete rileggere anche su questo blog (per la precisione qui), lo stanco, ciondolante detective d’albergo trasformato in orso dai potenti di Hollywood ha affondato di nuovo zanne e artigli nel mio volubile immaginario e ha ruggito il suo desiderio di tornare. Il risultato è un poema di 35 pagine, che compone l’intera prima parte della mia nuova raccolta di poesie, I labili confini, pubblicato di recente da Interno Poesia (lo trovate in libreria e sui grandi bazaar dell’e-commerce, ma ancora più semplice è ordinarlo qui sul sito dell’Editore). 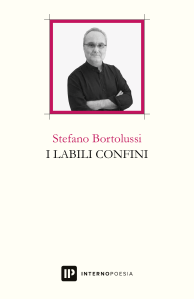
Di seguito, per gentile concessione dell’Editore, ne trovate una sapida anticipazione, ma se volete sapere come va a finire la nera avventura del plantigrado, e magari leggere le poesie della seconda sezione del libro (che, bando a pelosette modestie, Roberto Mussapi ha definito “composizioni di non comune potenza, lucentezza, nell’opera di un poeta italiano di oggi intatto da ogni minimalismo o sentimentalismo”) dovrete fare il nobile gesto di ordinare il libro, cedendo al molto meno nobile ricatto dell’autore a pezzi.
So che nessuno me l’ha chiesto, ma secondo me ne vale la pena.
LA SCELTA DEL PLANTIGRADO
– Un noir in versi –
Le sventurate imprese che di seguito si cantano
hanno un inizio che non è di queste pagine:
affonda le radici in terra di Califia
e nel libro che le è proprio, e narra
l’innato autolesionismo del plantigrado
che da detective e spione d’albergo
negli spenti corridoi del Marmont,
irretito da una rossa di miele d’acacia,
prese troppo sul serio il proprio incarico
in cerca delle storie smarrite da chi era uso
a possederle e le ritrovò dove loro,
i suoi mandanti in ville e grattacieli,
non avevano mai pensato di cercarle:
diffuse dal vento del deserto, inghiottite
dall’oceano, assorbite dalla terra assetata
di rinascita – in una parola: dappertutto
tranne che negli uffici in cui le avrebbero volute,
stanche e rinchiuse e pronte all’uso.
A scoperta più dolente non sarebbe potuto arrivare,
né rapporto più offensivo presentare,
nella città di ombre e apparenze: il nostro
orso d’albergo, forse malato d’illusione
oltre che dei suoi soliti tormenti, lo scoprì
a spese della propria letterale umanità,
già labile di suo, e non fece in tempo
a maledirsi per il peccato di superbia
che si ritrovò orso vero e proprio, bandito
oltrecollina insieme alla rossa strumentale
che, ormai disciolta in miele, era costretto
a ingollare in eterno – o almeno finché
lo spettacolo non fosse giunto a noia
ai suoi autori e distaccati spettatori.
Ma in terra di finali a piacimento
può essere che una trama si sciolga inusitata:
I.
Il santone in posizione di riposo mi guardava
con un misto di orgoglio soddisfatto e timore
di una delle metamorfosi spontanee
e più imprevedibili di un giro di vento
con cui ero assurto a fama scabrosa nella pace
del rifugio di meditazione in collina:
non ero ancora del tutto guarito, se da condanna
a forma animale da loro comminata è davvero
possibile guarire – in libertà condizionata
dall’esistenza quadrupede e ruggente
facevo spola tra dentatura cariata
e zanna gialla, unghia trascurata
e artiglio curvo, andatura oscillante
e passo rilassato in dirittura, mutando
spesso quando meno lo volevo e almeno
una volta seminando il panico in seduta
alla presenza di colui che con un misto
audace di trascendenza, percosse, funghi
magici, stimolazioni di amigdala e ippocampo
e farmaci d’assalto era riuscito a ridurre
di molto la mia natura ursina, riportandola
a tratto generale di carattere e tendenza
a ringhio e borbottio – se non, come dicevo,
nei momenti che chiamare inopinati è un eufemismo
in cui Natura tornava alla carica, fin troppo
generosa di bava e succhi vitali di altre,
più oscure gestazioni: allora era ognuno
per se stesso e dio per nessuno, e saluti cari
ai precetti del santone, forse il primo
e più lesto a rifugiarsi sui rami bassi
dell’eucalipto a lui sacro, senza pensare
a tendere la mano ai suoi discepoli.
Ma erano ormai settimane che non ruzzolavo
nella forra incolta e melmosa di foia
e istinti primevi, e se clinicamente
il risultato era il ritorno di compagnie
poco rimpiante (sciatica, Tourette, disturbo
bipolare) a circondare il cespuglio di guai
di natura metamorfica, nonché il pentimento
di avere prosciugato, coatto per condanna,
i dolci succhi della rossa di miele d’acacia,
dal punto di vista leggermente aereo
del santone ero un uomo, a volte un poco orso,
ma “non più pernicioso di agente hollywoodiano”.
(Cicatrici sparse di biografia pre-mistica,
in tale giudizio lontano da nirvana?
Shrapnel di oscuri ricordi della città di lustrini?
La sua risposta: “Sono guaritore, non guarito”.)
II.
Ed è così che con l’assenso del saggio e saldo
salato di fattura giunge il giorno del distacco
dalla tana a pagamento: vuoto di fondi
e pieno di punti di domanda sulla frase
da lui scelta a mo’ di congedo compio
i primi passi umani fuori dal ranch
sulle colline di Simi, provando un brivido
che al mio arrivo ursino mi eludeva:
siamo fin troppo vicini, lo si sente,
a quello che è stato altro rifugio ad altri
tipi di ferocia, evocata da parole che paiono
inventate (Spahn, Squeaky, Helter Skelter)
e che mi fanno scomodamente ripensare
a quelle finali del santone: un “Va’ e uccidi”
emesso a mezza voce, forse a ironico commento
sul mio doppio, spero con intento metaforico.
III.
In realtà alla prima tappa, anche se volessi
– o cedessi incolpevole a richiamo di ferocia –
non inciderei molto sul cadente stato delle cose:
il reperto mobile che si erge tra banco e parete
specchiata del bar potrebbe dare significato nuovo,
esistenziale sì ma in prima battuta esiziale,
al termine “Old Fashioned”: ordinandolo mi pare
di esalare qualcosa compreso nel vuoto di senso
tra omaggio e oltraggio, impressione confermata
da gemito e smorfia con cui lui si accinge
a miscelare whiskey angostura scorza e sudore
per produrre il peggior cocktail a ovest
della foresta di Los Padres (tracce quadrupedi,
maledizione, in questa coordinata di misurazione).
“Senza lavoro?” gracchia da sotto la lapide precoce,
divinando la mia condizione come se solo così
sarei potuto entrare in un simile locale
e ordinare tale malinconica miscela. “Centrato
e affondato” rispondo ancora chino sul liquido
ambrato che riporta ricordi di altre vertigini
e lappate (“Red, temo il momento in cui di te
non resterà nulla” pensavo immergendo il muso
nel suo miele; “Siamo ciò che siamo, non quello
che eravamo” avvertivo muta la risposta.)
Lui si muove in orizzontale dietro il banco
con fare da orso metallico di fiera ambulante,
e per un istante fuggitivo credo di vedere
qualcosa di comune dietro gli occhi, ma è solo
l’illusione del mutante. Il vecchio è vecchio,
punto e basta, e si muove come può. E adesso
crolla la testa come marionetta rimasta
senza fili, o forse venuta a noia al suo padrone:
“Ascoltami bene” dice, “perché potrei avere
una proposta su misura” emette con raucedine,
e io lo fisso con occhi a veneziana, per una volta
rimpiangendo di non saper essere feroce a comando,
quando ci sono pretese e arroganze da sgonfiare.
“Come fai, come sai, come puoi conoscere
quello che fa o non fa al caso mio?” mugugno,
confuso dal mio stesso uso della parola caso
che pessimi ricordi sembra raccogliere, frullare
e sputare all’intorno come schegge di case
da tornado. Lui: “Cosa credi?” dice, “hai piedipiatti
stampato in piena fronte”. Se solo sapessi, penso
riandando con parte della mente alla mia natura
stessa di plantigrado, ma poi mi sforzo
di rispondere nella tradizione dettata dal mestiere,
una spruzzata di bitters nel cocktail di spirito:
“Prediligo la pratica privata”, con strizzata d’occhio
a deragliare su binari di commento esistenziale.
Lui mi lancia uno sguardo di sbieco che sembra
mossa marziale da tanto è guizzante alla partenza
ma che si stanca prima dell’arrivo, vanificando
l’intenzione volitiva: “Ho una nipote” mormora
come a evocare pentimento, “o meglio l’avevo,
visto che nessuno da mesi l’ha più vista”.
Mosso a vibrazione dal suo nuovo tono,
o forse da un ribollio più umano di passaggio
nell’estuario inquieto delle mie nature,
gli chiedo se la scomparsa possieda la dubbia
distinzione di rispondere a un nome, a tratti
personali, a descrizione. “È nata Gabrielle”
risponde lui versando con trasporto,
“ma da sempre tutti la chiamano Gazelle.”
Primo vagito pre-senziente del detective:
per quale motivo il nomignolo zoomorfo?
L’antico barista mi legge come libro e volta
pagina del suo: “Ha linee e movenze
di cerbiatta, gambe di giraffa, occhi grigi
di lince boschiva, pelle come manto di visone.
Tutto quello che ci vuole, niente di meno,
per finire nelle fauci spalancate dei leoni”.
Titillato da un tale profluvio di animalità,
per un istante tentenno tra quattro e due zampe;
ma il successivo è invaso dal pensiero,
lungi dal festoso, che qui tutti i casi, con speciale
accento su quelli persi alla partenza, portano
alla città di luci e ombre, alle curve impreviste
delle strade nei canyon, alle ville abbarbicate
sui versanti tra carezze di eucalipti e cacti spinosi,
alle stanze buie dove il sogno si interrompe
come fotogramma sciolto e accartocciato
e l’incubo assume le sembianze di dio di risata,
di canto, avventura o amore romantico,
mostrando il suo volto, quello vero, alla vittima
di turno, incantata e sedotta a umiliare
corpo e spirito in eterno, o fino alla comparsa
di una nuova candidata alla rovina.
(Illustrazione: Noir Bear by emir0)
Guarda, con me potevi risparmiare tempo e fatica: non era assolutamente necessario mettere in campo il ricatto!
Il Plantigrado è un mito (in tutti i sensi) e questo poemetto lo conferma.
Ora vado a leggermi anche la seconda parte del libro: sono fiduciosa sul pari grado di soddisfazione, poi ti saprò dire con maggiori particolari, appena potrò.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie LadyJack, you’re a great lady!
"Mi piace""Mi piace"
Arrossisco…
"Mi piace"Piace a 1 persona